Cultura
Catechesi nell’arte – Il Buon Samaritano
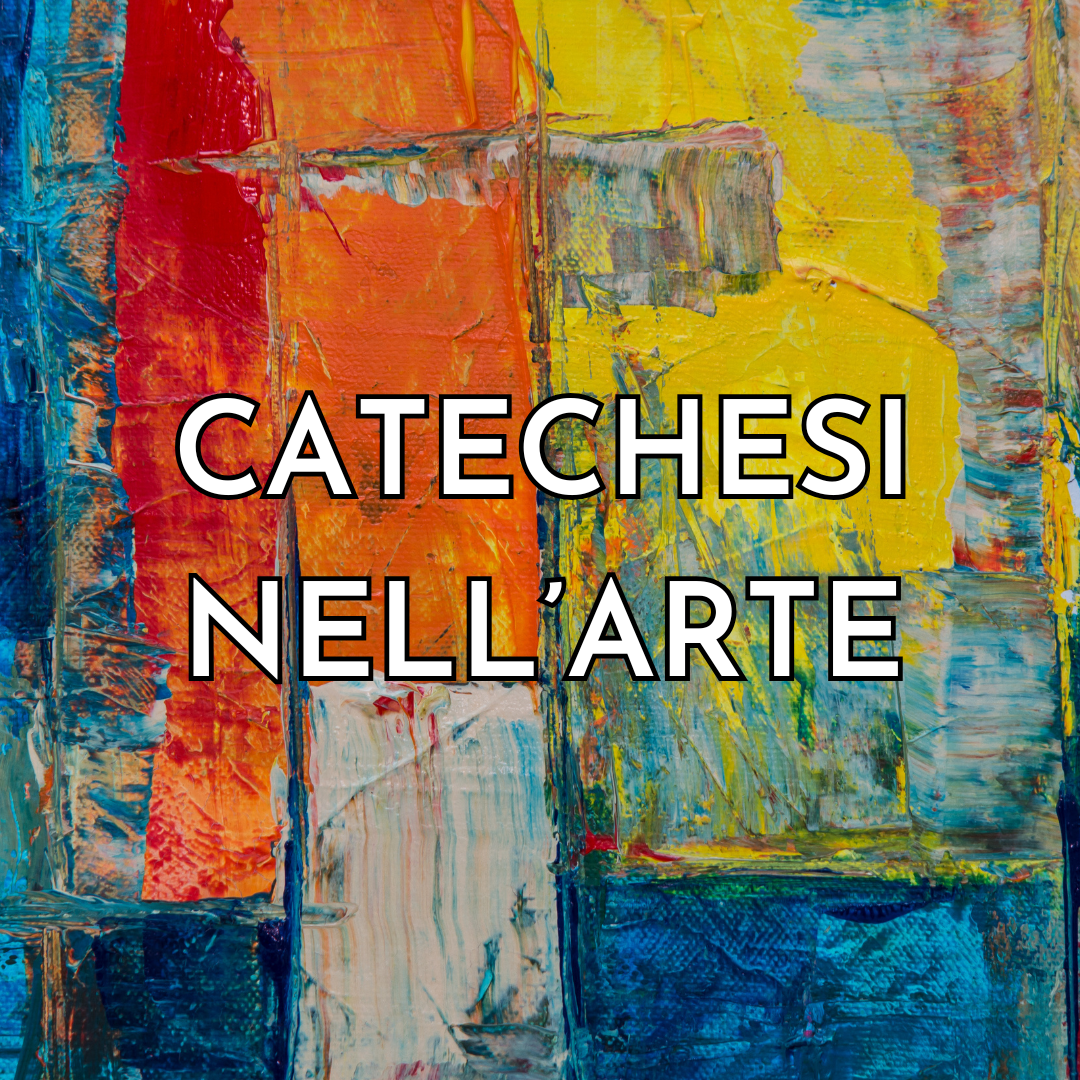
Nella sua predicazione Gesù in diversi modi, attraverso parabole, spiega come vivere la carità. Un esempio eloquente è la parabola del Buon samaritano (Lc 10,11-37). All’interno della produzione artistica questo brano evangelico, probabilmente per la difficoltà di sintetizzare in una sola immagine un racconto complesso, pare trovare poca fortuna iconografica pur essendo una delle parabole più raffigurate. Tra gli esempi ci sono le miniature dell’Evangeliario di Rossano (VI secolo) in cui il samaritano ha l’aspetto di Gesù. Se non si considerano, quindi, le illustrazioni all’interno dei volumi della Bibbia o i casi di alcune vetrate (come ad esempio quelle della cattedrale di Chartes, Bourges e Sens), o esempi piuttosto rari tra le sculture dei capitelli, si deve attendere il XVI secolo per riscontrare una certa ricorrenza. Nella miniatura del Codice Purpureo individuiamo subito l’ambiente: a sinistra Gerusalemme con le torri, l’arco, la cupola, gli alberi del monte degli ulivi; al centro, si staglia il Cristo che si piega verso il malcapitato prestandogli le prime cure, mentre un angelo gli porge una coppa con l’olio e il vino per curare le ferite; a destra, il ferito caricato su un asino viene condotto dal Samaritano alla locanda ed affidato alle cure dell’albergatore, cui porge due monete d’acconto per il ricovero. L’albergatore, visibile solo in parte, ha in mano un registro di cassa rilegato in rosso.

Nella cattedrale di Sens la vetrata del buon samaritano e accanto a quella del figlio prodigo. In questa vetrata, secondo il pensiero di sant’Agostino, la parabola è interpretata come riassunto simbolico della storia della salvezza: ogni tappa del racconto evangelico è commentata da episodi di questa storia che chiariscono la parabola, che, a sua volta, ne rivela il significato teologico. 1. L’uomo ferito: l’uomo che scendeva da Gerusalemme (la città santa) a Gerico (la città dei pagani) è figura dell’umanità privata della sua dignità originaria e dimentica della sua vocazione di immagine di Dio. La vetrata commenta questo episodio rimandando alla storia della caduta e del peccato originale: si stabilisce un gioco di corrispondenze: a Gerusalemme corrisponde il giardino dell’Eden; al viaggiatore Adamo ed Eva; ai banditi il serpente; al fatto di scendere volontariamente verso Gerico, l’accettazione della proposta del serpente l’espulsione dal giardino. 2. L’uomo abbandonato: per commentare l’indifferenza del sacerdote e del levita l’autore della vetrata ha scelto gli episodi celebri della storia di Mosè. L’accento è messo qui sulla volontà di Dio di salvare il suo popolo e sulla molteplicità delle proposte di salvezza. Dio si fa conoscere da Mosè nel roveto ardente e gli rivela il suo nome. Dio salva il suo popolo dalle mani del faraone assistendo Mosè e Aronne dando loro il potere di compiere miracoli. Dio libera gli ebrei dai serpenti del deserto facendo alzare il simulacro del serpente di bronzo. A questi tre atti liberatori dalla forza cattiva degli idoli, degli uomini e della natura, risponde una tentazione simbolo di tutte le tentazioni: l’adorazione del vitello d’oro. La veste del sacerdote e del levita sono quelle del prete e del diacono indica che anche la Chiesa cristiana pecca spesso su questo punto. 3. L’uomo salvato: il terzo episodio della parabola è messo in relazione con l’azione di Gesù. Come il buon samaritano Gesù è colui che salva l’uomo ferito e che lo conduce all’albergo perché sia curato. In lui Dio realizza il piano d’amore che era il suo quando ha creato l’uomo. Per questo sono presenti gli episodi fondamentali della Passione e della Resurrezione. Sono delle donne le prime a ricevere l’annuncio: mentre Eva era stata l’intermediaria della tentazione, le donne sono promosse al ruolo di messaggeri di gioia e al ruolo di primi apostoli davanti agli uomini. Nell’albergo, immagine della Chiesa, l’uomo riconciliato con Dio è reintrodotto nella società dei suoi fratelli, in quanto nessuno può andare senza l’altro.

