Cultura
Catechesi nell’arte – La rappresentazione del Papa nell’arte figurativa
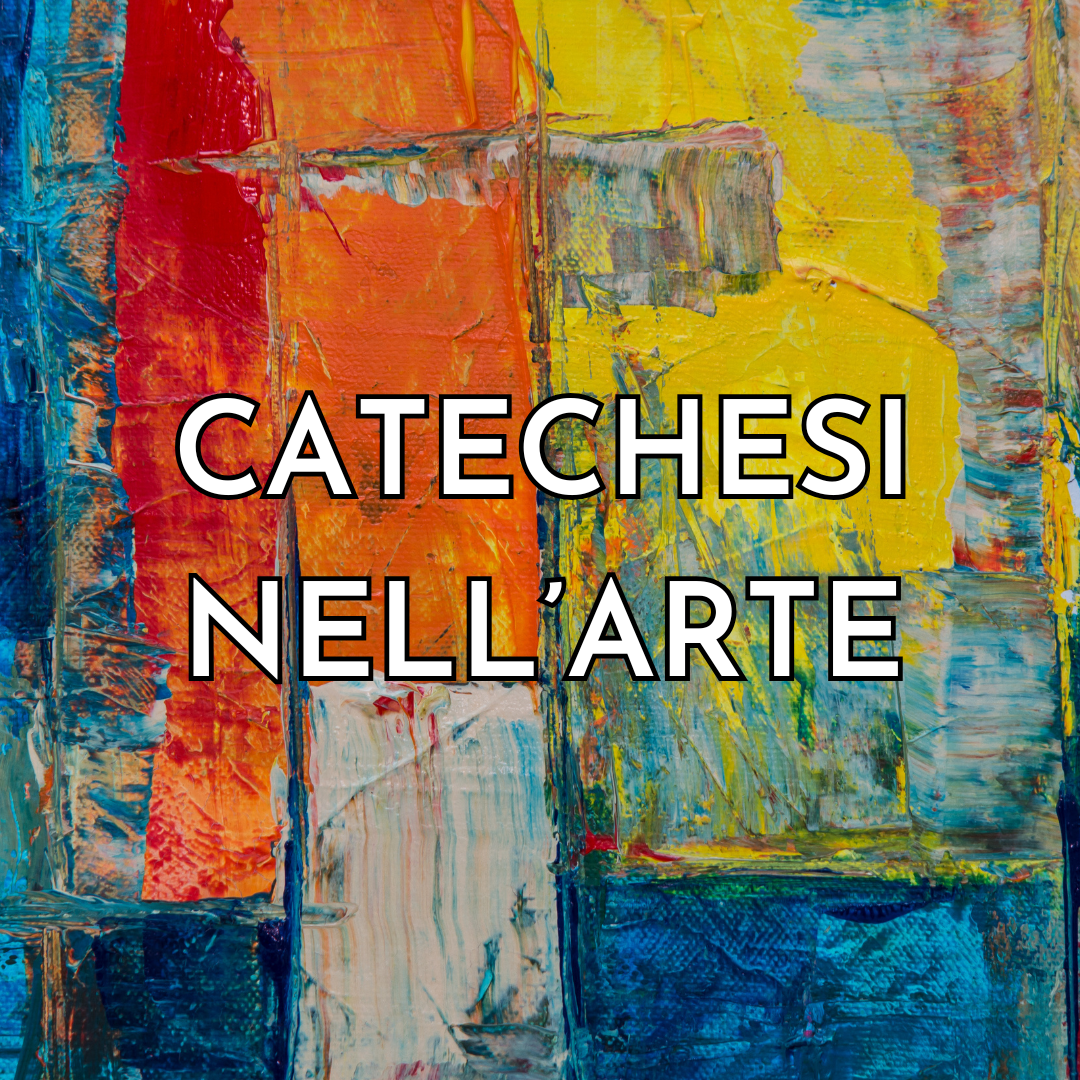
L’arte, in tutte le sue forme, ha rappresentato i papi con insistenza quasi ossessiva. E questo non per mera ritrattistica ufficiale, ma per un bisogno più profondo: comprendere l’umanità e la solennità di un’istituzione che, pur essendo radicata nel sacro, resta profondamente terrena. Fin dai primi secoli, la figura del pontefice — successore di Pietro — ha trovato spazio nella rappresentazione artistica. I mosaici paleocristiani delle basiliche romane, come quelli di San Paolo fuori le Mura o Santa Maria Maggiore, già restituivano l’idea del papa come testimone e custode della fede: un’icona tra le icone, non ancora individualizzata ma già autorevole. Con il Medioevo, il ritratto assume contorni più marcati. Le miniature dei codici liturgici e le pitture murali, come quelle di Cimabue o Giotto, iniziano a distinguere i papi attraverso attributi riconoscibili: la tiara, il piviale, la croce papale. Ma è con il Rinascimento che l’immagine del papa entra nella piena era della rappresentazione. Si pensi al monumentale ritratto di Giulio II di Raffaello (1511–12), custodito oggi alla National Gallery di Londra. Il pontefice non è mostrato nell’atto di benedire, né in trono, ma seduto, pensieroso, le mani congiunte in una tensione trattenuta. Raffaello compie una rivoluzione: il papa non è solo un’istituzione, è un uomo. È potere, dubbio, meditazione. In quello stesso periodo, Michelangelo, sotto commissione papale, trasforma la Cappella Sistina in un racconto cosmico dove il papa diventa garante visibile del disegno invisibile di Dio. Nel Barocco, con Bernini, la teatralità della figura papale esplode: i busti di Urbano VIII o Alessandro VII catturano il respiro del potere, lo splendore del marmo che diventa carne. I ritratti, ora, sono anche diplomazia, propaganda, controllo. Il papa viene rappresentato come figura regale e spirituale insieme: l’apice dell’arte cortigiana.

Con la modernità, il ritratto papale si fa sempre più soggetto di interrogazione. La secolarizzazione porta con sé uno sguardo meno reverente. Il potere spirituale viene spesso colto nel suo lato ambiguo, o addirittura perturbante. È celebre il caso di Francis Bacon e la sua serie di “Papi urlanti”, ispirati liberamente al ritratto di Innocenzo X di Velázquez. In queste opere, il pontefice — figura di autorità massima — è deformato, urlante, imprigionato in gabbie invisibili. L’urlo che Bacon dipinge è il rovescio dell’infallibilità, la carne viva dell’uomo sotto il peso dell’istituzione. Non si tratta di un attacco anticlericale, quanto di una vertigine esistenziale: cosa resta dell’autorità quando l’immagine si sgretola? E poi ci sono i fotografi: Steve McCurry, Oliviero Toscani, Sebastião Salgado — ognuno a modo suo — ha immortalato l’autorità spirituale non come entità statica, ma come presenza incarnata: l’anziano che prega, l’uomo tra la folla, il gesto della mano che benedice e consola. In questo lungo racconto, si inserisce ora l’ultima pagina: Papa Francesco. A differenza di molti predecessori, non è stato un grande committente artistico. Non ha promosso nuove decorazioni, né grandi progetti estetici. Ma ha incarnato un linguaggio simbolico potente, fatto di scelte e gesti che parlano più di molte opere. Il crocifisso nero, la croce pettorale in ferro, l’abbandono dell’oro e della porpora. La rinuncia all’appartamento pontificio, la predilezione per i viaggi nelle periferie, l’attenzione ai volti più che alle cornici. Francesco ha riportato il sacro nella quotidianità e ha restituito alla figura papale una forza iconica tanto più incisiva quanto più essenziale. Anche la sua immagine ha generato arte. Non tanto nei circuiti ufficiali, quanto nella street art, nei disegni dei bambini, nelle illustrazioni digitali, nei poster che lo ritraggono come “Papa del popolo”. Non è un’estetica della magnificenza, ma della prossimità. Un’estetica povera, come quella di San Francesco, a cui ha voluto legarsi sin dal nome. Oggi, mentre il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, l’arte che rappresenta i papi ci offre uno specchio in cui osservare ciò che resta. Non solo il volto di un papa, ma il riflesso di un’istituzione millenaria e del nostro bisogno di rappresentarla. L’arte ha sempre saputo cogliere — e spesso anticipare — le trasformazioni del sacro. Ha smascherato il potere, ha celebrato la spiritualità, ha scavato nella contraddizione. E forse, proprio in questo sguardo molteplice, si rivela il mistero della figura papale: un uomo che porta il peso del divino, ma cammina nella polvere del mondo. In fondo, i papi sono stati — e saranno ancora — figure liminari, sospese tra il cielo e la terra.

